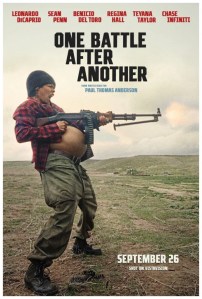Da tempo rifletto sul modo in cui le parole, quando si deformano in grido o sospetto, possono diventare il primo mattone dell’odio. Questo dialogo nasce dal tentativo di guardare alla violenza politica da un luogo altro, metastorico, dove i fatti del presente si travestono da mito e le nostre ferite prendono voce attraverso personaggi antichi. Non è un’allegoria, non è un apologo: è una domanda. Chi accende davvero l’odio? E noi, con le nostre parole, da che parte stiamo?
Personaggi
- Narratore
- Ipocrate, devoto di Trumpókleitos
- Dikaios, indagatore della verità
Proemio
Dalla quiete del monte Hýperion, dove l’aria è pura e gli ulivi ammantati d’argento custodiscono il silenzio, scesi in città, riluttante e con l’animo greve, poiché da quell’eremo lo sguardo si perdeva sull’immensa distesa azzurra dell’Egeo. In lontananza, sparse sullo specchio cupreo del mare, le barche dei pescatori brillavano come fiammelle tremanti.
Il monte, tempio dimentico del tempo, mi tratteneva ancora. Pure, già da alcuni giorni, un messo dell’Archōn Pythodōros era giunto fino a me, recando la richiesta di un consiglio che non potevo rifiutare.
Dicevano che la città fosse preda di torbidi e di sospetti: che gli uomini non si fidassero più gli uni degli altri, e che ogni parola fosse accolta come un’arma. Nelle piazze si gridava di libertà e di patria, ma nessuno ricordava più che cosa significassero; gli dèi tacevano, e gli uomini, non udendo che se stessi, prendevano le menzogne per oracoli, e le grida per sapienza.
L’Archōn mi pregava di scendere dalla solitudine per recare consiglio, poiché molti parlavano, ma pochi ragionavano, e la città sembrava avviarsi verso il disordine.
A lungo indugiai, poiché il silenzio del monte mi era più caro del clamore degli uomini; ma infine mi mossi, persuaso che anche il tacere, quando si prolunga oltre misura, diventa colpa.
Inoltratomi per gli irti dirupi che portano alla città, giunto a valle, cominciai a udire il frastuono e i discorsi vuoti degli uomini, che delle inezie fanno monumento e le grandi trascurano.
Si levava il brusio del mercato: le voci, i commerci, la vita che non tace mai. Subito mi parve d’essere straniero in mezzo ad amici, e che la città tutta fosse scossa come da venti contrari, orchestra di discordie e clamori. Con quest’animo giunsi infine alle porte del Dipylo, attratto dalla speranza di udire un discorso degno di verità e di saggezza, e di scoprire se, tra gli uomini, ve ne fosse ancora qualcuno capace di cercare il giusto.
Così, scivolando per le strade, si dischiuse davanti a me una piazza ombrosa, ricca di platani, allori e ulivi; tutt’intorno, cespi di mirto profumavano l’aria mescolandosi al silenzio e all’aroma dolce e salmastro del mare. Lì mi colpì la veemenza di una discussione tra due uomini. Avvicinandomi, riconobbi nell’uno Ipocrate, fervente devoto di Trumpókleitos – glorioso a parole, vuoto in sostanza – e del movimento che nella terra dell’Occaso chiamano “MAGA”, kenon mega, phōnē pollē (grande vuoto, molta voce). L’altro era Dikaios, di natura critica, solito indagare la verità attraverso domande serrate.
Mi fermai ad ascoltarli. E poiché Mnemosyne, madre della memoria, mi concesse alla nascita un dono prodigioso, ciò che segue è il resoconto, pressoché fedele, del loro discorso.
Ipocrate: O Dikaios, tu sai bene quale sciagura sia caduta su di noi: la città, agitata da voci contrarie, è divenuta simile a una nave senza timone. Non senti anche tu l’ingiustizia che ci opprime? Kerkíōn, caro agli occhi del popolo, è caduto per mano di un folle; ed egli, che fu difensore della libertà, della sacralità della vita e dei confini della nazione contro l’ingresso degli stranieri – male che mescola genti ostili e dissolve l’identità di un popolo – è oggi divenuto martire della libertà. Così egli è, per tutti noi, degno di onore e memoria.
Dikaios: Dunque Ipocrate, affermi che Kerkíōn è martire?
Ipocrate: Sì, martire e simbolo.
Dikaios: Eppure dimmi, non fu per benevolo intervento degli dèi che Dēmosthénēs e sua moglie Aspasía scamparono alla mano fanatica? E non furono invece Melíssa e suo marito Eirenaion a cadere? Perché il loro sangue non meritò lutto? Non caddero anch’essi per morte violenta?
Ipocrate: Non so. Forse perché non diventarono simboli.
Dikaios: E chi decide quali morti diventino simboli e quali no? Non sono gli uomini tutti uguali davanti alla morte?
Ipocrate: Così dovrebbe essere, ma la memoria del popolo segue altre vie. La memoria obbedisce alle passioni dei vivi.
Dikaios: E non è vero che furono quelle passioni a piegarsi alla voce di Trumpókleitos?
Egli parlò degli attacchi con leggerezza, senza distinguere il dolore di chi cadde. Disse che convocare l’Archōn Lýsias sarebbe stato “uno spreco di tempo”. E disertò i funerali, quando ancora non si conosceva la verità di ciò che era accaduto.
Ipocrate: Così si racconta.
Dikaios: Dimmi, Ipocrate: non fu forse lui a chiamare “nemici del popolo” i cittadini radunati nell’ekklesía? Non fu egli stesso a lanciare epiteti ingiuriosi contro gli avversari, Hilliopē l’ingannevole e Narkíōn lo sbadigliatore, come se l’oltraggio fosse ormai divenuto la moneta corrente della politica?
E a Mantineia, non parlò di “uomini di grande probità”, equiparando gli autòchthones, sostenitori dei Trenta Tiranni, ai loro oppositori?
Non fu poi lo stesso a decretare un bando contro gli stranieri – e a chiamare “animali” i meteci, coloro che abitano tra noi ma non condividono i nostri diritti?
E infine, non gridò di elezioni truccate, spingendo i suoi seguaci a marciare sull’Areopago, nel sesto giorno di Gamelione?
Ipocrate: Non in questo senso, Dikaios, come tu riferisci.
Infatti non chiamò “nemici del popolo” i cittadini tutti, ma solo coloro che tramavano contro la città. E i soprannomi, che tu dici ingiuriosi, erano piuttosto segni di franchezza e di parresia, affinché il popolo riconoscesse l’inganno dei retori.
Quanto a Mantineia, non mise sullo stesso piano i sostenitori dei Trenta e i loro oppositori, ma ricordò che in entrambi vi erano uomini di probità, come pure di malvagità: ché la virtù non appartiene a una sola parte. E se decretò un bando per gli stranieri, lo fece a difesa dell’identità della città, non per odio.
Quanto alle elezioni, egli non parlò di frode, ma mise in guardia contro l’ingiustizia. E i suoi seguaci, quando marciarono sull’Areopago, non cercarono rivolta, bensì giustizia.
Dikaios: Dici dunque che non chiamò “nemici del popolo” i cittadini, ma soltanto alcuni? Eppure fu proprio nell’ekklesía che levò quelle parole, e contro coloro che non acconsentivano al suo volere.
E i tuoi epiteti li chiami parresia? La parresia è il coraggio di sciogliere la lingua davanti agli uomini, senza veli né timore. È il dono e la condanna di chi osa dire tutto, anche quando la verità punge come ortica. La franchezza riguarda la verità, non l’oltraggio; ché l’insulto non illumina, ma acceca.
Quanto a Mantineia, se virtù vi era da entrambe le parti, perché allora celebrò gli autòchthones e tacque sugli altri? Non è forse così che si corrompe la giustizia, quando si chiama uguale ciò che non è uguale?
E il bando agli stranieri, lo chiami difesa della città? Chi allontana il forestiero allontana anche la possibilità dell’amicizia. Lo straniero non è colui che arriva da fuori, ma colui che arriva; sempre: il veniente, l’inevitabile. Egli non abita altrove, abita l’attesa.
E noi, ciechi, chiudiamo le porte. Diciamo: “Difendiamo la città.” Ma la città — che cos’è, se non il luogo dove qualcuno può ancora venire? L’amicizia nasce da quell’apertura: da una soglia lasciata socchiusa, da una voce che chiama e non si sa da dove. L’accoglienza non è un ordine, ma una supplica, una promessa che si teme di mantenere.
Chi bandisce lo straniero bandisce il futuro. Bandisce se stesso, poiché ciascuno è straniero a sé, ospite nella propria casa, nella propria lingua, nel proprio corpo. E allora dimmi: quale città difendiamo, se difendendola la cancelliamo?
Infine, se non parlò di frode ma solo di ingiustizia, perché i suoi seguaci marciarono armati sull’Areopago, se non perché li aveva resi ciechi col suo grido?
Ipocrate: Non vedi, Dikaios, che tu stesso fai ciò che rimproveri? Tu moltiplichi le parole e i sospetti, e li presenti come se fossero verità.
Quanto ai cittadini dell’ekklesía, egli li chiamò nemici non perché lo fossero di fatto, ma per svegliarli dal torpore: ché spesso chi dorme ha bisogno di un grido aspro per destarsi. E se gli epiteti paiono oltraggi, ricorda che anche Omero ne diede non meno duri: Achille il piè veloce, Paride l’imbelle.
A Mantineia poi, egli lodò la probità, non di una parte sola, ma di coloro che seppero rimanere fedeli alla città, in qualunque schiera si trovassero.
Quanto agli stranieri, non v’è amicizia senza misura: troppa luce acceca, Dikaios, come troppo vino ubriaca la fraternità.
La città è un corpo, Dikaios, e il corpo non può restare integro se non distingue tra ciò che lo nutre e ciò che lo corrompe. Non sopravvive senza pelle. La pelle separa e custodisce, distingue il calore dal veleno, il nutrimento dal morso.
Quando troppi entrano, anche l’amico diventa peso: la soglia si logora, la casa smarrisce il nome inciso sul suo stipite. Tu invochi l’ospitalità, ma l’ospitalità senza confine è resa: l’apertura totale è un diluvio che spegne il fuoco, che confonde il volto nell’acqua.
La città vive di limiti, come il respiro vive dell’intervallo tra due fiati. Io non odio lo straniero: temo solo che, nel nome dell’accoglienza, si perda la forma che ci tiene insieme; temo il giorno in cui nessuno sarà più straniero, e dunque nessuno più amico. Senza forma, non c’è volto; senza volto, non c’è più città, ma un brusio d’anonimi che nessuno conosce.
Infine, sull’Areopago essi marciarono non per cieco furore, ma perché la giustizia è come un fuoco: non si lascia guardare senza ferire, né servire senza consumarsi. Arde e purifica, ma divora anche chi pretende di custodirla; poiché la giustizia non abita in nessuno, e tuttavia tutti la portano come una brace nel petto.
Dikaios: Vedi, Ipocrate, che i tuoi giri di parole non ti salvano?
Se chiamare i cittadini “nemici” è un grido che desta, allora perché li spinse a combattersi fra loro? Se il bando degli stranieri è misura, perché si fonda sulla paura e non sulla giustizia? E se la marcia fu giustizia, perché lasciò dietro di sé violenza e disordine?
Ammettilo dunque: le tue difese non reggono.
Ipocrate: Ma dimmi: non è forse vero che la parola, quando scuote, può sembrare oltraggio e nondimeno generare verità? E non è forse accaduto più volte che lo straniero, accolto senza misura, abbia indebolito la città invece di rafforzarla? Ancora: non credi che la giustizia, per ardere, debba talvolta attraversare quel caos che gli animi timorosi scambiano per disordine, ignorando che il caos è l’apertura originaria da cui tutto prende forma, l’apertura che tutto espone e rivela?
Dikaios: Forse. Ma quando la parola ferisce più di quanto illumini, non è verità: è veleno. Quando lo straniero diventa pretesto di paura, non è misura: è esclusione. E quando la giustizia incendia la città, non resta che cenere.
Ipocrate: Vedo allora che le stesse ragioni con cui difendo diventano armi contro di me. Eppure ti chiedo: non è compito della politica sopportare anche il rischio dell’errore, pur di non lasciare la città inerte?
Dikaios: Sì, ma il rischio non deve mai farsi legge. Perché, se l’errore diventa costume, la città non si muove: si perde.
Ipocrate: Le tue parole sono dure, e tuttavia non prive di Alētheia, la dea che squarcia i veli dell’oblio e costringe gli uomini a reggere lo sguardo della verità. Non posso negarlo.
Dikaios: Questo ti rende onore.
Ma dimmi, per amor di verità, se è così, non vedi allora come Trumpókleitos si nutra dell’odio che diffonde? Che il movimento che guida abbia reso naturale il sospetto, il disprezzo, la violenza verbale e infine quella fisica? Che abbia reso naturale parlare con rabbia verso chiunque non sia allineato? Che, in questo clima, gli attacchi contro gli amici del dēmos, come quello di Hybristḗs, non siano un incidente, ma piuttosto il frutto di una lunga semina?
Ipocrate: Forse sì. Ma non hanno colpa anch’essi, coloro che dall’altra parte insultano, deridono, accusano?
Dikaios: Non lo nego. Ma ascolta, Ipocrate, e rifletti con me. Noi crediamo spesso che le parole siano vento leggero, che passano e si dissolvono. Le parole sono semi. Alcuni cadono e muoiono, ma altri trovano terra fertile, mettono radici e diventano idee. E quando le idee crescono, producono azioni, e le azioni diventano storia. Non è forse più grave la colpa di colui che detiene la voce più possente e il potere di un’intera nazione? Se due insultano, ma uno è un semplice cittadino, mentre l’altro governa la città, non pesa forse di più la parola di quest’ultimo?
Narratore: Dalle parole di Dikaios mi parve — un’ombra passeggera che attraversava la mia mente — di scorgere un segno antico, una ruota solare che girava nella luce. Ma la ruota si torceva, come afferrata da una mano invisibile, e si faceva ramo d’ombra, sigillo di morte, olezzo di carne bruciata. Non compresi allora quel presagio: solo molto tempo dopo — interrogando l’oracolo — avrei appreso che, in terre lontane e in secoli futuri, tale segno sarebbe stato volto al male e posto a guida di stermini. Ma in quell’istante tacqui, e prestai di nuovo ascolto.
Ipocrate: Vuoi dire che i discorsi hanno la stessa forza delle armi?
Dikaios: Più ancora. Ricorda, Ipocrate: vi furono tempi in cui un Tiranno del Settentrione — un uomo che fece dell’antico segno del sole il suo sigillo di morte e distruzione — incise in un unico libro il delirio della purezza della razza; e da quelle pagine, come da un seme d’ombra, presero forma forni e stermini.
Con parole i colonizzatori giustificarono la schiavitù degli Aithíopes e lo sterminio degli autòchthones delle nuove contrade d’Occidente, invocando missione e civiltà.
E a Oriente, Ipocrate, sorse un altro potere: non di razza ma di Dottrina.
Il Sovrano delle Steppe innalzò la monochthonía, la Dottrina della Zolla Unica, sostenendo che tutti gli uomini dovessero essere figli della stessa terra, uguali come semi sparsi sulla stessa zolla.
Ma ciò che nasce dalla terra non tollera la costrizione, e la Dottrina, che prometteva fratellanza, si fece ghiaccio.
Allora cominciarono le Notti dei Carri: villaggi svuotati, case ridotte al silenzio, moltitudini sospinte verso le Case del Gelo, dove il respiro si spezza prima dell’alba. Così accadde che un principio nato per abolire il dominio si trasformò in dominio più duro, e il popolo — che doveva essere il tutto — fu decimato come se fosse nemico.
E più a Sud ancora, si levò il Coro della Notte, che insinuava nelle piazze che alcuni erano insetti e non uomini. E coloro che impugnarono il ferro credettero davvero di schiacciare vermi, non di versare sangue umano. E dunque, se Kerkíōn tacque di fronte agli assassinii di Hybristḗs, se condivise quel linguaggio aggressivo, non cadde anch’egli vittima di quel medesimo clima che il suo campo aveva reso legittimo? Non dobbiamo forse dire che Trumpókleitos stesso, pur non alzando la mano, armò quella di chi colpì? Non è paradossale che chi si nutrì della retorica dell’odio sia stato poi divorato da essa?
Ipocrate: Dunque anche Kerkíōn sarebbe vittima di Trumpókleitos?
Dikaios: Non lo affermo con certezza. Ma i fatti lo lasciano pensare: l’odio, una volta liberato, non risparmia nessuno, neppure coloro che lo hanno brandito.
Talvolta le parole aprono abissi e sollevano tempeste. Quando trovano un animo fragile, generano il gesto estremo: l’assalto, la marcia armata, la strage.
Perciò, non illuderti che un uomo sia innocente solo perché non impugna l’arma. Chi arma la lingua prepara la mano. Chi parla con odio costruisce la mente che un giorno scioglierà la corda dell’arco.
Ipocrate: E allora chi dobbiamo piangere come martiri? Solo gli amici del dēmos? Solo Kerkíōn? Nessuno? Chi accende l’odio, se non sappiamo distinguere il carnefice dal seminatore di parole avvelenate?
Dikaios: Non lo so. So soltanto che piangere alcuni e tacere sugli altri è ingiustizia. Ma queste sono le domande, Ipocrate — e temo che resteranno senza risposta.
Epilogo
Così il loro discorso si spense nel silenzio, e Ipocrate tacque, incapace di replicare, come chi in cuor suo avverte la forza delle parole udite.
Io, che avevo ascoltato, mi allontanai pensoso, dimentico della convocazione dell’Archōn.
La città pareva adesso quieta, come dopo una tempesta. Le voci del mercato tacevano, e solo Nótos, vento del Sud, si insinuava tra le vie, portando con sé frammenti di parole simili a ceneri leggere.
Incamminatomi verso il monte, compresi che non solo le armi, ma il lógos stesso sia signore di vita e di morte nella città; ché dalle parole nascono i gesti, e dai gesti la sorte degli uomini.
Mi resi conto che solo chi dubita interroga chi davvero alimenta l’odio, e che solo interrogando possiamo sapere se le nostre parole edificano la giustizia o innalzano muri d’inimicizia.
Dinanzi a me, Hýperion già riposava, dolcemente ammantato dal velo silente delle Pleiadi.
Solo allora una domanda sopraggiunse, come una stella che dal firmamento si spegne sulla terra: chi alimenta davvero l’odio?
E noi, con le nostre stesse parole, da che parte stiamo?
Davide Matera, MNR, 16 settembre – 25 ottobre 2025