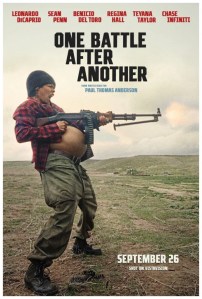Dalla sospensione del fondamento al sospetto permanente
La cosiddetta “fine della verità” non è un evento improvviso né una moda culturale recente. È il risultato di un processo filosofico lungo e profondo che ha progressivamente eroso l’idea occidentale di verità come fondamento stabile, universale e garantito. Questa erosione trova in Nietzsche un momento decisivo, non perché egli distrugga semplicemente la verità, ma perché ne mette a nudo la struttura.
Quando Nietzsche afferma che non esistono fatti ma solo interpretazioni, non invita al disordine cognitivo. Sta mostrando che ciò che chiamiamo “fatto” è già il prodotto di un’organizzazione di senso. Nel saggio Su verità e menzogna in senso extramorale, la verità viene descritta come un sistema di metafore che, attraverso l’uso, si sono irrigidite fino a sembrare naturali. La verità non è l’accesso puro al reale, ma la stabilizzazione di figure linguistiche di cui abbiamo dimenticato l’origine.
La proclamazione della morte di Dio nella La gaia scienza radicalizza questa trasformazione. Non si tratta solo della crisi della fede religiosa, ma della dissoluzione del garante ultimo del senso. Senza un fondamento trascendente, la verità non può più presentarsi come necessità assoluta. Essa diventa prospettiva.
Ma prospettiva non significa capriccio. Il prospettivismo nietzscheano non equivale a un relativismo indifferente. Ogni interpretazione è espressione di una forza, di una volontà di potenza che struttura il mondo secondo gerarchie, valori, priorità. Non esiste un dato neutro che preceda l’interpretazione: il reale è sempre già inscritto in un campo di forze. L’interpretazione non è un velo che deforma; è il modo in cui il mondo prende forma per noi.
Con Nietzsche la verità perde la sua innocenza metafisica, ma acquista una dimensione etica. Se non esiste un fondamento ultimo, allora siamo responsabili delle interpretazioni che produciamo e sosteniamo. La fine della verità come assoluto non libera dall’obbligo del giudizio; lo rende più esigente.
Con Michel Foucault il discorso si storicizza ulteriormente. La questione non è più soltanto che la verità sia interpretazione, ma che essa sia prodotta all’interno di dispositivi di potere. In opere come Sorvegliare e punire e La volontà di sapere, la verità appare inseparabile dalle pratiche che la rendono operativa. Ogni società costruisce un proprio regime di verità, un insieme di istituzioni, procedure, criteri di validazione che stabiliscono ciò che può essere detto come vero.
Il sapere non è esterno al potere. Produce soggetti, definisce normalità, delimita il dicibile. Se Nietzsche aveva mostrato che la verità è costruzione, Foucault mostra che essa è anche amministrazione.
Con Jacques Derrida la critica investe la struttura stessa del significato. In Della grammatologia, la tradizione occidentale viene interrogata nella sua fiducia in un senso pienamente presente. Derrida mostra che il significato è sempre differito, mai completamente presente a sé stesso. Ogni pretesa di fondamento è attraversata da una differenza che la destabilizza.
La verità non è semplicemente falsa; è strutturalmente incompleta. Non può mai chiudersi in una presenza piena e definitiva. Questa consapevolezza non distrugge il discorso razionale, ma ne rivela la complessità.
In questo contesto, la cosiddetta “post-verità” contemporanea appare come l’esito distorto di un lungo processo critico. La perdita di fiducia nelle autorità tradizionali del sapere ha prodotto una proliferazione di interpretazioni che competono nello spazio pubblico. Tuttavia, è necessario distinguere tra la critica filosofica del fondamento e la degenerazione relativistica che domina molte dinamiche dei social network.
La messa in questione della verità non autorizza l’equivalenza delle opinioni. Il fatto che ogni discorso sia situato non implica che ogni discorso sia fondato. Eppure, nel dibattito digitale, l’idea che “tutto sia interpretazione” viene spesso ridotta a una giustificazione per l’arbitrio. L’interpretazione diventa opinione immediata, sganciata da verifica, argomentazione, competenza.
Il complottismo rappresenta una forma estrema di questa deriva. Si presenta come esercizio di spirito critico, ma opera attraverso una logica chiusa: ogni dato contrario è riassorbito come prova ulteriore del complotto. La sospensione del fondamento si trasforma in sospetto permanente. Non si analizzano le condizioni di produzione del vero; si sostituisce l’analisi con la paranoia.
Qui non siamo di fronte a un eccesso di filosofia, ma alla sua assenza. Nietzsche non invita a credere a qualsiasi narrazione alternativa; invita a riconoscere le forze che producono senso. Foucault non suggerisce che ogni discorso sia falso; mostra come esso sia situato in un regime di verità. Derrida non legittima l’indifferenza epistemica; rivela la complessità strutturale del significato.
L’ignoranza che alimenta molte dinamiche dei social non consiste solo nella mancanza di informazioni, ma nell’incapacità di distinguere tra ipotesi e prova, tra dubbio metodico e sospetto indiscriminato. L’algoritmo privilegia l’intensità emotiva, non la solidità argomentativa. In questo ambiente, l’interpretazione si riduce a reazione, e la reazione si traveste da consapevolezza.
La fine della verità come fondamento non coincide con la dissoluzione dei criteri. Al contrario, richiede criteri più rigorosi. Senza disciplina intellettuale, la pluralità interpretativa degenera in rumore. Senza responsabilità, la critica diventa cinismo.
La crisi contemporanea non è aver scoperto che la verità è costruzione. È aver dimenticato che ogni costruzione esige lavoro, competenza, confronto, revisione. La genealogia e la decostruzione non aprono uno spazio di anarchia cognitiva, ma di maggiore responsabilità.
Se la verità è interpretazione, allora interpretare è un atto che implica conseguenze. In questo spazio si decide se un discorso accresca la comprensione del mondo o la riduca a narrazione paranoica. La differenza non sta nel numero delle interpretazioni, ma nella loro qualità.
La filosofia, oggi, non serve a restaurare dogmi perduti. Serve a impedire che la critica venga confusa con l’arbitrio, che il dubbio si trasformi in sospetto sistematico, che l’interpretazione degeneri in fantasia consolatoria. La fine della verità non è un trionfo dell’ignoranza. È una prova di maturità. Sta a noi dimostrare di esserne all’altezza.
Davide Matera, MNR, 18 febbraio 2026