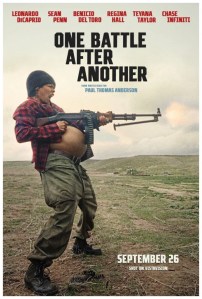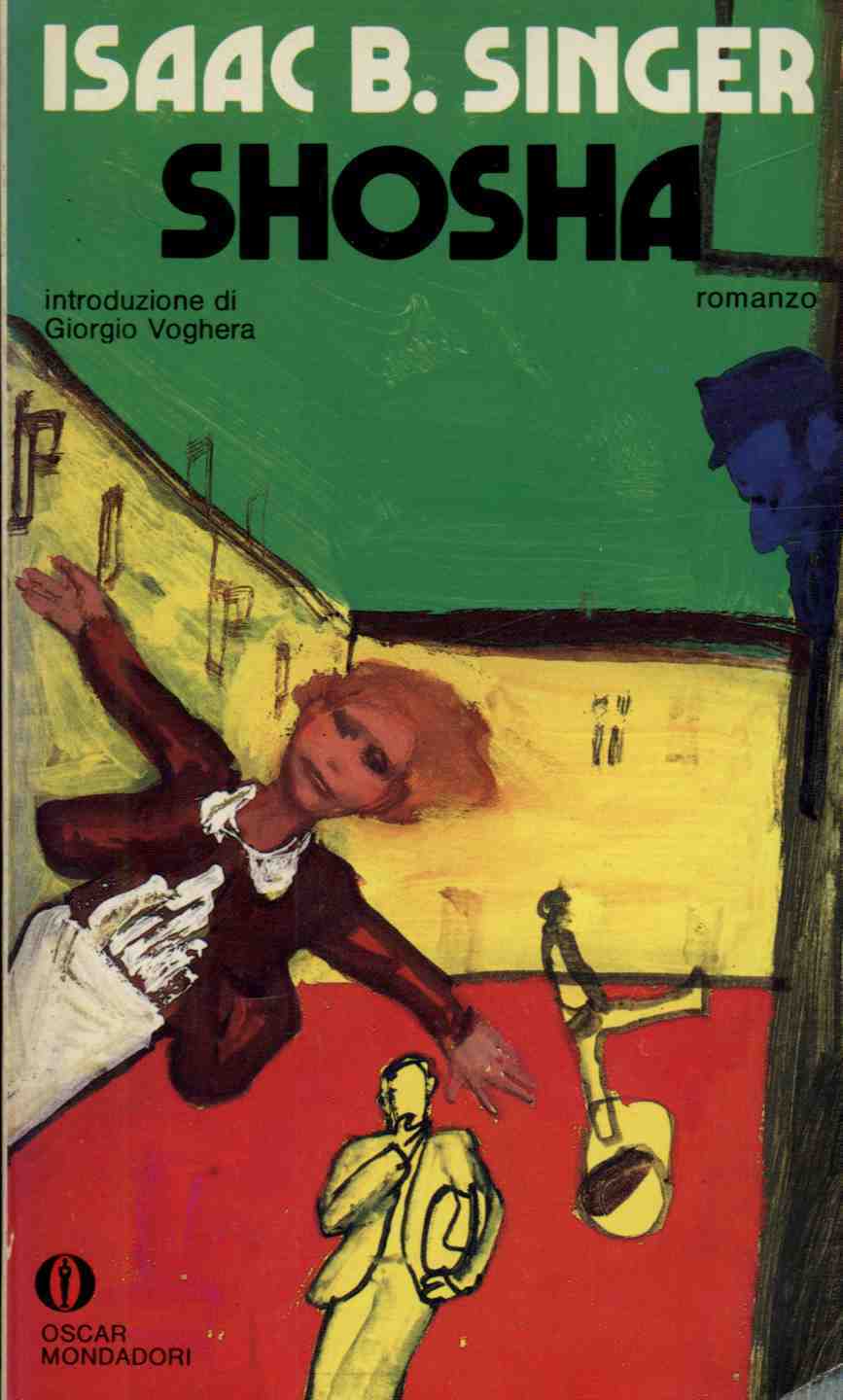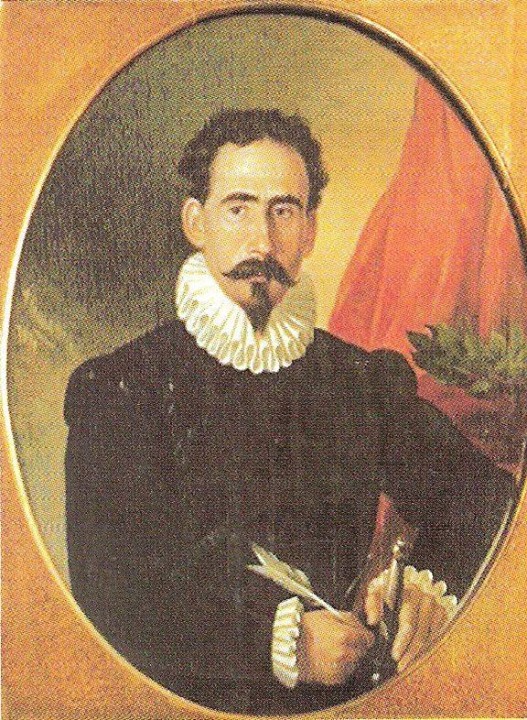Nel cinema di Paul Thomas Anderson non c’è mai stata fiducia nelle soluzioni, né sul piano narrativo né su quello morale. Fin dagli esordi, Anderson ha mostrato una costante diffidenza verso le narrazioni risolutive, politiche comprese, preferendo osservare ciò che accade dopo l’evento. I suoi film non sono attraversati da momenti fondativi, ma da processi di logoramento: famiglie che si sfaldano, comunità che si irrigidiscono, forme di potere che sopravvivono a sé stesse anche quando hanno perso ogni giustificazione simbolica.
In questo cinema, il conflitto non produce redenzione. Produce residui, scarti, sopravvivenze. Non libera, ma consuma. È a partire da questa postura autoriale, coerente e mai smentita, che Una battaglia dopo l’altra può essere letto non come un film “sulla politica”, ma come un film che pensa politicamente il tempo presente, interrogando la possibilità stessa di una rottura all’interno di un ordine che sembra aver imparato a nutrirsi del conflitto.
In Una battaglia dopo l’altra, la politica non è mai un contenuto esplicito, ma una forma del tempo. È in questo senso che il film può essere messo in dialogo, senza forzature, con tre pensatori che hanno interrogato la violenza, l’oppressione e la ripetizione ben oltre la cronaca: Walter Benjamin, Simone Weil e Jacques Derrida.
Benjamin, nel suo celebre saggio Per la critica della violenza, distingue tra una violenza che fonda il diritto e una violenza che lo conserva. Ciò che Anderson sembra mostrare è un mondo in cui questa distinzione si è dissolta: la violenza non fonda più nulla, ma continua a conservarsi da sola, come un meccanismo che non ha bisogno di legittimazione ulteriore. Le battaglie del film non aprono spazi nuovi, non interrompono l’ordine esistente, ma lo mantengono in uno stato di tensione permanente. È una violenza senza evento, senza soglia, senza “ora messianico”. In termini benjaminiani, manca la frattura capace di sospendere il continuum della storia.
Questo spiega perché la rivoluzione, nel film, non accade mai davvero. Non perché sia repressa, ma perché è stata inglobata nella logica stessa del potere. La lotta non è più l’eccezione che spezza il tempo, ma la sua normalità amministrata. L’America che Anderson osserva sembra vivere in una condizione in cui ogni gesto antagonista è già previsto, metabolizzato, neutralizzato prima ancora di produrre un effetto reale. È qui che il riferimento implicito all’America trumpiana diventa più profondo: non l’autoritarismo come rottura, ma come permanenza.
Simone Weil permette di spingere il discorso ancora oltre. Nei suoi scritti sull’oppressione, la filosofa francese insiste su un punto spesso rimosso dal pensiero rivoluzionario: il fatto che chi combatte l’oppressione rischia costantemente di riprodurla, non per malafede, ma per necessità strutturale. Il potere, per Weil, non risiede solo nelle istituzioni, ma nelle forme impersonali della forza che attraversano i corpi e i linguaggi. In Una battaglia dopo l’altra, questa intuizione diventa carne narrativa. I personaggi non sono corrotti, né traditori; sono logorati. La loro azione non si perverte, si irrigidisce. La resistenza smette di essere risposta all’ingiustizia e diventa abitudine, ruolo, identità.
È per questo che Anderson rifiuta la figura del leader carismatico. Un capo, nel film, non potrebbe che accelerare la trasformazione della lotta in apparato. L’assenza di una guida non è una mancanza narrativa, ma una presa di posizione teorica coerente con tutto il suo cinema: la rivoluzione che si organizza come potere è già sconfitta, perché ha accettato le stesse categorie che pretendeva di rovesciare.
Con Derrida, infine, il film trova forse la sua risonanza più sottile. Derrida ha mostrato come ogni promessa di rottura radicale sia sempre abitata dalla ripetizione, dal rinvio, dalla contaminazione con ciò che vorrebbe superare. La rivoluzione pura è un fantasma; ciò che esiste è una differenza che si produce sempre all’interno di una continuità. Anderson sembra assumere fino in fondo questa inquietudine. Una battaglia dopo l’altra è un film sull’iterabilità della lotta, sul fatto che ogni gesto antagonista porta con sé il rischio di diventare una copia sbiadita di quelli che lo hanno preceduto.
In questo senso, il film non è né riformista né rivoluzionario. È più radicale e più disperato. Non chiede come rovesciare il potere, ma come interrompere la sua capacità di riprodursi dentro di noi. La vera tirannia, nell’America che Anderson filma, non è solo un governo o ciò che ne resta come trauma politico; è la normalizzazione del conflitto, la sua trasformazione in rumore di fondo, in destino.
Per questo Una battaglia dopo l’altra non offre una via d’uscita. Non perché Anderson non ne veda nessuna, ma perché sospetta che ogni via d’uscita dichiarata rischi di diventare immediatamente una nuova forma di cattura. Il film resta allora in una zona scomoda, quasi eticamente pericolosa, in cui la critica non si traduce in programma e la resistenza non si converte in redenzione.
È un cinema che non salva, ma vigila.
E oggi, forse, è già moltissimo.
Resta tuttavia necessario precisare che questa lettura non pretende di ricostruire le intenzioni consapevoli di Paul Thomas Anderson, né di attribuirgli una posizione teorica o politica esplicitamente formulata. Anderson non lavora per tesi, né per allegorie programmatiche; il suo cinema non “dice” ciò che pensa, lo produce come effetto. Il senso che emerge da Una battaglia dopo l’altra non coincide con una volontà autoriale dichiarata, ma con ciò che il film rende pensabile, spesso al di là delle categorie con cui l’autore stesso potrebbe descriverlo.
È proprio in questo scarto che l’opera trova la sua forza critica. Un film non è mai la semplice espressione dell’intenzione di chi lo realizza, ma un dispositivo che entra in relazione con il proprio tempo, lo assorbe e lo restituisce sotto forma di inquietudine. Una battaglia dopo l’altra non offre risposte perché non nasce per rispondere; registra una condizione, la espone, la lascia operare. E in un presente saturo di posizioni, dichiarazioni e programmi, questa sospensione non è una fuga dalla politica, ma una delle sue forme più esigenti.
MNR, 17 gennaio 2026